Flavio Tarquini, responsabile delle collezioni scientifiche dell’Orto botanico di Roma, è la massima autorità del nostro rione sul tema. Con lui abbiamo parlato degli incendi che hanno colpito la macchia pluviale la scorsa estate
Lo scorso agosto i media di tutto il mondo hanno dato la notizia dell’aumento record degli incendi nella foresta pluviale amazzonica. Le fiamme, appiccate dolosamente, stanno incrementando la deforestazione mettendo a rischio la biodiversità della foresta e le popolazioni indigene. A finire sotto accusa sono stati i trafficanti di legno, i grandi coltivatori e l’attività mineraria in cerca di nuove terre da sfruttare. Ma soprattutto il presidente Bolsonaro, che sembra intenzionato a difendere altri interessi. Per cercare di capire meglio cosa sta accadendo in Amazzonia e quali possono essere le ricadute sulla vita di ognuno di noi, siamo andati a parlare con Flavio Tarquini, botanico dell’Università di Roma La Sapienza e responsabile scientifico delle collezioni dell’Orto botanico di largo Cristina di Svezia. Oltre a ospitare importanti collezioni estese sui suoi 12 ettari (dove spiccano i bambù, il bosco mediterraneo, il roseto, le piante acquatiche e gli alberi monumentali), l’Orto Botanico di Roma è impegnato nella conservazione della diversità biologica in ogni sua componente, compresa quella riferibile ai sistemi agricoli. Il dottor Tarquini si occupa dei servizi educativi rivolti alle scuole, delle visite guidate, degli eventi presso l’Orto ed è autore del libro “Guida del Museo Orto Botanico di Roma”.
Stupito dallo stupore “Giudico positivamente il risalto che quest’estate è stato dato dalla stampa al tema degli incendi in Amazzonia, anche se quella non è la sola foresta pluviale che sta bruciando in questo memento sul nostro pianeta. In ogni caso, l’attenzione mediatica è sempre un fatto positivo, se non altro perché obbliga anche i potenti del mondo a interessarsi a questi problemi, che generalmente vengono ignorati anche per la mancanza di conoscenza delle tematiche ambientali”. Quello che stupisce però il botanico è proprio lo stupore con cui queste notizie vengono accolte. “Sono decenni che l’Amazzonia brucia incessantemente. Da come è stata data la notizia sembra invece che gli incendi siano iniziati solo adesso, quando in realtà stanno solo aumentando. Quando ero ancora all’inizio del mio percorso universitario, il WWF lanciò una campagna in difesa dell’Amazzonia, mostrando come all’epoca, a causa degli incendi dolosi, ci fossimo già giocati una porzione di foresta delle dimensioni dell’Austria. Parliamo di circa venticinque anni fa”. Un altro rischio, secondo Tarquini, è dato dalla cattiva informazione che viene data dai media che tentano di spettacolarizzare eventi che andrebbero trattati con maggiore attenzione scientifica. “Dire che quella amazzonica è la più grande foresta del mondo è lanciare una fake news. La più estesa è la taiga, che si trova tra la Russia e la Scandinavia, che pur avendo una scarsissima varietà di specie (è composta quasi esclusivamente da abeti, n.d.r.) occupa una superficie più vasta. Sembra una sciocchezza, ma fornire un’informazione sbagliata rischia di deviare il discorso portando a minimizzare quello che sta realmente accadendo”.
Perché l’amazzonia brucia La foresta pluviale amazzonica si estende sulla fascia equatoriale dell’America meridionale, in un’area dove non esistono cambi repentini di stagioni e in cui il clima è tendenzialmente caldo umido. In questo tipo di foreste convive una quantità elevatissima di biodiversità, di gran lunga maggiore rispetto ad altri tipi di vegetazioni non pluviali.
Bruciando un tratto di foresta amazzonica si ottiene inizialmente un terreno con una resa agricola eccellente, proprio grazie alle biodiversità di cui sopra, non solo vegetale ma anche ricca di decompositori e di batteri. Con l’incendio, queste specie tornano immediatamente al terreno rendendolo estremamente ricco. Il problema, come spiega il dottor Tarquini, è il modello di insediamento intensivo che si rifà a quello europeo impiantando specie vegetali che non appartengono né a quel terreno né a quel clima. Nell’arco di 6 o 7 anni questi insediamenti diventano sterili, costringendo gli agricoltori a bruciare un’altra sezione di foresta per poter continuare a coltivare. Il terreno abbandonato, fortemente sfruttato e privo di humus, è destinato a diventare una landa desolata difficilmente coltivabile, di cui nessuno si cura più. Quanto è stato sfruttato trent’anni fa ora non è più recuperabile, non è più fertile. Non si può chiedere all’Amazzonia di essere l’orto del mondo e di produrre quei prodotti a cui non possiamo rinunciare. La coltura di specie erbacee secondo le coltivazioni europee, con quel tipo di clima e con quella vegetazione, è semplicemente improponibile. “Se non si cambia il metodo di utilizzo del suolo in Amazzonia, il processo di desertificazione sarà inarrestabile. Prodotti come l’orzo, il caffè, il grano, la barbabietola e tutti gli altri che fanno parte del repertorio agricolo europeo non possono essere coltivati su quei terreni. Sarebbe come coltivare kiwi ad Avezzano al posto delle patate”.
Cosa ci stiamo perdendo Con l’avanzata del deserto, le perdite a livello scientifico, etnologico ed etnobotanico sono incalcolabili. La ricchezza della foresta amazzonica risiede principalmente in tutte quelle specie che ancora non sono state raccolte e studiate. All’interno della sua biodiversità potrebbero esserci delle piante non note destinate a uso medicinale, i cui estratti potrebbero potenzialmente guarire malattie a oggi incurabili. “Se non si conosce una molecola non è possibile sintetizzarla. Se si brucia della vegetazione ignota si brucia anche la possibilità di cure, di alimentazione, di sintesi tessile naturale. La foresta Amazzonica è uno dei hot spot botanici, uno dei punti caldi della terra dove in un determinato spazio corrispondono un certo numero di specie, al 90% sconosciute. Gli sciamani delle tribù indigene hanno sicuramente trovato un modo di sfruttare la vegetazione a scopo medicinale, oltre a preservarla essendo la loro unica fonte di sostentamento”.
La foresta inoltre è dimora di quasi un milione di indigeni divisi in 400 tribù, ognuna delle quali con una diversa lingua e una diversa cultura. Alcune di queste hanno relazioni con l’esterno da oltre 500 anni, altre invece non hanno mai avuto rapporti con diversi tipi di società e, di conseguenza, un qualsiasi contatto batterico portato da fuori potrebbe portare a conseguenze estremamente dannose.
Che si può fare? Alla luce di questo quadro, non sono molte le alternative per tentare di cambiare rotta. “L’opzione più estrema è quella di lasciare l’Amazzonia ai suoi legittimi abitanti, gli Indios, rinunciando così alla sua giurisdizione e allo sfruttamento del suo terreno per fini commerciali. Altrimenti, una soluzione potrebbe essere la creazione di un parco gestito e tutelato a livello internazionale, con vaste porzioni a riserva integrale dove non possa essere minimamente toccata la vegetazione e il cui ingresso venga concesso esclusivamente a fini di ricerca scientifica”. Come detto, coltivare specie erbacee secondo i modelli agricoli europei nelle zone equatoriali è letale per il terreno. “L’unico modo per tentare di recuperarlo – secondo Tarquini – sarebbe reimpiantare coltivazioni di piante arboree, in equilibrio con il clima e con la vegetazione propria dell’Amazzonia”. In pratica, la comunità internazionale dovrebbe studiare un progetto volto a recuperare quella porzione di foresta ormai desertificata, ricostruendo il terreno attraverso l’impianto di concimi e piante che possano fornire l’humus che prepari il suolo a un nuovo insediamento di una foresta pluviale. “Questo però ci imporrebbe inevitabilmente di modificare il nostro stile di vita: non potremmo più mangiare i pop corn o la carne tutti i giorni, trovare al supermercato i peperoni a dicembre o i mandarini ad agosto. Come, in realtà, sarebbe giusto che fosse”. Un cambio di mentalità epocale, che però non può avvenire senza la spinta di chi governa oggi il mondo. “Si è parlato di questo problema anche all’ultimo G7, fatto senza dubbio positivo. Solo mi chiedo: se a quel tavolo siedono i rappresentanti dei paesi più industrializzati, dove hanno la propria sede le multinazionali responsabili dello sfruttamento e quindi degli incendi in Amazzonia, come ci si può aspettare che possano adottare soluzioni che vadano contro i loro stessi interessi?”. L’uomo non ha la capacità di distruggere il mondo. Il pianeta è sopravvissuto a molti cambiamenti climatici. La natura risponde su lunghi periodi e può averne perfino dei giovamenti. È l’uomo, pur sentendosi il più grande dei predatori, che deve adattarsi per non estinguersi. Damose ‘na regolata.






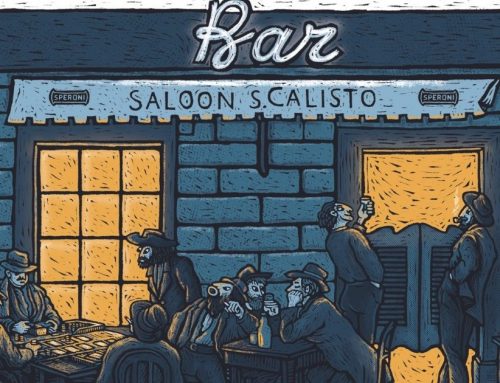

[…] Precedente Prossimo […]
[…] ANCHE: Dall’Orto di Trastevere alla foresta amazzonica, The circle, Er colloquio de […]